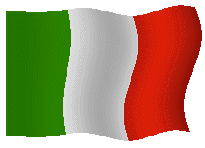E da amica è rimasta al loro fianco fino all’8 marzo quando ormai la minaccia del contagio giganteggiava anche sui suoi due ambulatori, a Mira e a Borbiago, e sopra di lei ogni volta che entrava in un appartamento per una visita a domicilio. Medico, mamma, musulmana, Samar Sinjab era nata in Siria 62 anni fa. Aveva lasciato Damasco per venire a studiare medicina in Italia, all’Università di Padova, dove tra i suoi compagni e connazionali ha incontrato Omar El Mazloum. Lei ha scelto Medicina generale, lui Pediatria e, insieme, sono diventati il «dottor Omar» e la «dottoressa Samar», due punti di riferimento nella comunità di 40 mila abitanti a ovest di Venezia, sulla Riviera del Brenta. Dal loro matrimonio sono nati due figli. Due nuovi dottori. Rafi, medico legale, e Dania, pediatra come il padre. «Era così fiera di loro — ricorda adesso Paolo Zambon, titolare della farmacia di Borbiago vicina allo studio di Samar Sinjab —. Ma aveva sempre tempo per tutti. Una volta che mi aveva sentito un po’ mogio al telefono, mi richiamò dopo venti minuti per chiedermi che cosa potesse fare per me. Siamo andati a mangiare una pizza insieme. Margherita, per lei, musulmana. Era una presenza importante per le donne arabe immigrate qui».
Dall’inizio dell’epidemia la dottoressa Samar ha tentato in ogni modo di «fermare il vento con le mani», per usare l’espressione del suo collega Stefano Righi. Per settimane senza dispositivi di protezione, guanti, mascherina, visiera. Solo con il camice bianco e una smisurata dose di altruismo, pur sapendo di essere più vulnerabile di altri per qualche patologia pregressa. «Sono stati i pazienti, a volte, a portarci le mascherine — rammenta il dottor Righi —. Non siamo militi ignoti, siamo noti, ma ignorati». Tredici anni fa un infarto acuto, al ritorno da un congresso, aveva portato via improvvisamente Omar dalla vita della dottoressa Samar che aveva deciso di prendersi cura anche dei pazienti del marito e di dividersi fra due ambulatori. Non resteranno orfani nemmeno i mutuati di Samar: «Dato che l’ho sempre sostituita io e li conosco tutti — ripete il figlio Rafi —, vorrei portare avanti il suo lavoro». Ma non senza tutele, come sua madre: «Dateci una mano. Perché ricordatevi che avrete bisogno di noi. Ricordatevi di noi e non solo in questo momento» hanno pregato dai microfoni della Rai Dania e Rafi. La centesima vittima dei camici bianchi non potrà avere tutto il paese al suo funerale, ma non lascia un posto vuoto.