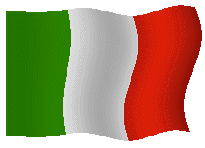È come varcare la porta di un sogno. Un sogno meraviglioso, tanto grande quanto si passeggia sorridenti tra camerini e stand. H&M è un’azienda che vanta di esistere dal 1947, quando venne fondata in Svezia da Erling Persson. ‘Per lei’ si chiamava – Hennes in svedese – perché produceva con cura solo abiti femminili. Per le donne, dunque, donne che forse negli anni ’40 erano diverse per cultura e stile, ma sempre le stesse in quanto a gusto e amore per lo shopping. Donne che vogliono essere coccolate dal colore e dallo ‘scintillio’ delle vetrine, ammaliate da abiti per tutti i gusti e magari con la possibilità di non subire un duro colpo nel guardare il prezzo. Da H&M tutto questo è possibile e molto di più. Di più perché anche un meraviglioso sogno può trasformarsi in un incubo.
Alliance Asia Floor (AFWA) – una coalizione globale di organizzazioni sindacali che si occupa di proteggere i diritti dei lavoratori e i diritti umani – ha pubblicato un allarmante studio sul proprio sito. È abbastanza diffuso il sapere che le grandi catene occidentali ormai producono esclusivamente all’estero in Paesi a basso reddito, per lo più nel sud-est asiatico, ma non era ancora nota la condizione delle operaie delle fabbriche H&M che si trovano in Cambogia e India, due dei Paesi dove l’azienda produce la maggior parte dei capi. Qui le operaie non solo lavorano 16-18 ore al giorno per paghe da fame, non solo fanno extra che di solito non rientrano nello stipendio, qui le operaie subiscono violenza e se dovessero restare incinte o abortiscono o sono licenziate. L’Asia Floor Wage Alliance ha intervistato 251 dipendenti per conoscere le loro condizioni di lavoro e ha svelato situazioni “scioccanti”. Lo scopo è stato quello di dimostrare che dietro gli abiti che ci fanno sognare per qualità-prezzo, le mani che li producono appartengono a donne sfruttate e trattate oltre i confini dei diritti umani. Milioni di persone che lavorano anche per 16-18 ore al giorno con uno stipendio molto al di sotto di quello che considereremmo “salario minimo”, in condizioni igienico-sanitarie spesso molto precarie e senza tutela alcuna. E le grandi catene dell’abbigliamento, da Zara a Primark passando per Gap e per la stessa Hennes & Mauritz, ne approfittano. “In tutti questi Paesi i lavoratori dell’abbigliamento sono in gran parte donne – dichiara Giovanni D’Agata presidente dello ‘Sportello dei Diritti’ – di solito provenienti da zone rurali o comunque dagli strati più vulnerabili della società. Molestie sessuali, miserie quotidiane, perfino le pause per la toilette vengono negate, anche nei giorni mestruali: impressionante sentire giovani operaie che sfidano pregiudizi e intimidazioni per testimoniare cosa significa consumarsi in fabbrica”. Ma in particolare “Secondo il rapporto, in 11 fabbriche cambogiane su 12, i dipendenti sono stati testimoni di situazioni di interruzione della gravidanza o ne sono state vittime. Tutti i 50 dipendenti delle fabbriche indiane intervistati hanno anche svelato che per le donne era comune essere licenziate durante la gravidanza”. Inoltre, i contratti interinali da uno a tre mesi prevedono che se qualcuno prende un giorno di assenza per malattia, arriva in ritardo o si rifiuta di lavorare fuori orario, corre il rischio di non vedere rinnovato il contratto “. Le condizioni di lavoro, spingono molte giovani donne, che rappresentano oltre l'85% del numero dei dipendenti, all'aborto per evitare di perdere il lavoro.
“L’industria dell’abbigliamento – continua il presidente D’Agata – è un sistema globale in cui, da un lato ci sono imprese di Paesi industrializzati che vendono abiti e abbigliamento sportivo, di solito con marchi noti; dall’altro, ci sono i produttori di quegli abiti. Le note marche occidentali in effetti non producono più nulla. Hanno smesso da tempo di avere fabbriche proprie; si limitano a commissionare i loro modelli a fabbricanti sparsi in Paesi a basso reddito e basso costo del lavoro, per lo più in Asia: una decina di paesi dell’Asia meridionale e del sud-est oggi sforna il 60% dell’abbigliamento mondiale, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del commercio. Questo significa che l’impresa europea o statunitense non ha alcuna responsabilità verso gli operai che cuciono i suoi vestiti: non sono suoi dipendenti”. Ma lavarsi le mani dalla responsabilità dei dipendenti, forse per renderle lucide agli occhi di chi comprerà quei vestiti, non lava via le macchie di orrore che affligge la vita di quei lavoratori. “Alla luce di questo studio – conclude il presidente D’Agata – ci auguriamo che grazie al tam tam del web, la denuncia di Alliance Asia Floor cominci a prendere il largo, diventando virale insieme alla sua iniziativa di boicottare H&M e i suoi abiti, spingendo H&M a prendere provvedimenti nei confronti dei laboratori tessili a cui commissiona la realizzazione degli abiti”.